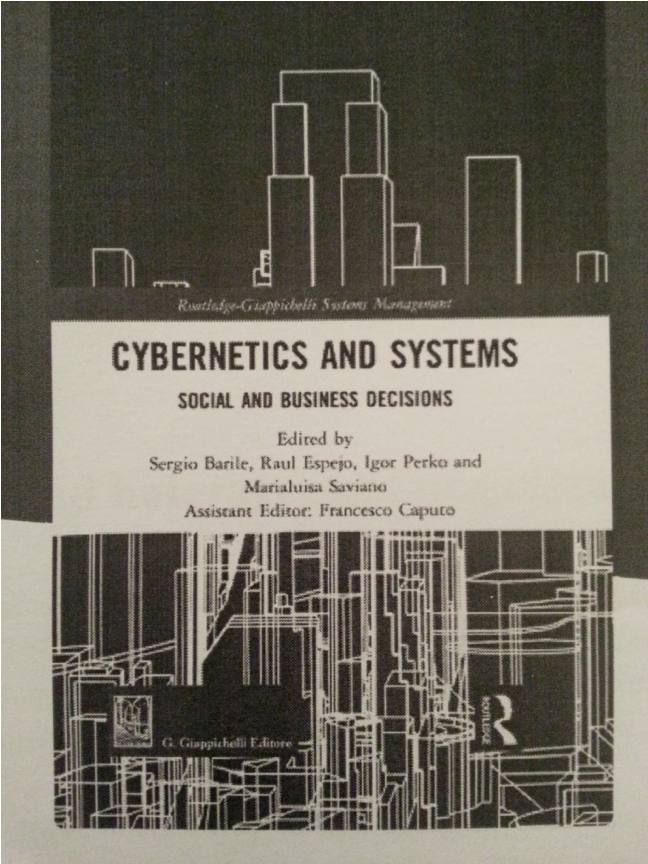Un punto di vista sull’etica
Come rappresentante del modello sistemico mi preme iniziare sottolineando il cambiamento paradigmatico nel modo di pensare la scienza e nel percepire l’insegnamento, l’apprendimento, il processo terapeutico, la ricerca, il managment e altre pratiche collettive proprie di questo modello. Seguendo i dettami della cibernetica di secondo ordine (Telfener, Casadio 2003) immaginiamo un attore partecipante nell’intensità delle reciproche interazioni, nel dare e prendere circolare delle relazioni umane; un soggetto che si pone in maniera attiva e partecipata rispetto a ciò che lo coinvolge e che ha rinunciato al mito dell’oggettività per favorire la consapevolezza e la necessità di condividere valori culturali e personali intersoggettivi, organizzati da una riflessività costante.
Per parlare di etica scelgo quindi uno dei rappresentanti più significativi del modello sistemico, che ha esplicitamente trattato l’argomento in maniera sufficientemente estesa, sostenendo l’ineluttabilità di assumere una posizione etica. Mi riferisco a Heinz von Foerster[1], epistemologo di fama internazionale, che nel 1990 a Parigi partecipando ad un convegno sull’etica, rifletteva sulla necessità di non esplicitarla attraverso proposizioni del tipo “tu devi”, “si dovrebbe” per non diventare moralisti. Il rischio di chiamarsi fuori e individuare doveri e proibizioni è quello della moralizzazione, il mettersi in un punto esterno e privilegiato di osservazione del processo e stabilire regole che saranno ineluttabilmente definite dal contesto, dalla cultura, dal periodo storico, se non addirittura dalle idiosincrasie della persona che “pontifica” e decide.
Rifacendosi a Wittgenstein von Foerster citava due proposizione dell’opera che secondo lui avrebbe dovuto chiamarsi “Trattato Etico-Filosofico”:
la 6.421: “è chiaro che l’etica non può venir articolata”,
la 6.422: “quando si definisce una legge etica nella forma ‘si dovrebbe’, il primo pensiero diventa ‘e cosa succede se non lo faccio?’” … e continua: “E’ chiaro che l’etica non ha niente a che fare con punizioni e premi nel senso usuale del termine. Pur tuttavia ci deve essere una sorta di ricompensa e punizione etica, ma devono risiedere nell’azione stessa”
Come possiamo nascondere l’etica dagli occhi di tutti e permetterle di determinare il linguaggio e le azioni (del processo terapeutico, oltre che della vita) senza cadere nel moralismo? – si domandava von Foerster e proseguiva – “Fortunatamente l’etica ha due sorelle che le permettono di essere invisibile in quanto creano una cornice visibile, un intreccio tangibile nel quale e sul quale possiamo tessere le trame della nostra vita.” Le due sorelle sono la metafisica e la dialettica.
Diventiamo metafisici ogni volta che decidiamo su questioni indecidibili per principio. “Solo su quelle questioni che sono indecidibili per principio possiamo decidere …. Non c’è nessuna necessità esterna che ci forzi a rispondere in un modo o in un altro. Siamo liberi! L’opposto di necessità non è possibilità, l’opposto di necessità è scelta. Ma con questa libertà di scelta siamo ora responsabili per quello che scegliamo.” Accettare una posizione metafisica significa per von Foerster soprattutto assumersi la responsabilità del fatto che non sappiamo, riconoscendo l’ineluttabilità di punti ciechi nel processo della conoscenza. Implica quindi comportarsi in terapia non come esperti ma come partecipanti ad una interazione cui devono collaborare tutti coloro che sono implicati, per arrivare a formulare ipotesi che siano sempre temporanee: fare ipotesi adattative e processuali, che possano offrire una mappa condivisa, non oggettiva, per spiegare cosa ci viene portato.
Da un punto di vista clinico definirsi metafisici implica:
A. Fare una scelta epistemologica,
decidere dove ci si posizione, come si considerano gli umani, la terapia, il processo stesso del cambiamento. Scegliere se definirsi realisti o costruttivisti[2] e piazzarsi nel continuum lungo la linea tra i due estremi.
B. Sapere di non sapere, avventurarsi in aree sconosciute,
non fare affidamento su una pianificazione top down né basarsi solamente su ciò che si sa: la comprensione degli eventi è incompleta e va bene così in quanto proprio questa incompletezza permette di fidarsi dell’intuito, di affiancare tecnicismo e creatività, di allontanarsi da un percorso ripetibile e triviale, sempre uguale. Solo una prassi che tenga conto della inevitabile ignoranza del clinico, che assuma la possibilità di non controllare e non saturare, che si muova comodamente in territori non controllati e che rinunci all’expertise permette di non rispondere in maniera normalizzante (risposte ortopediche) ma in maniera processuale ed evolutiva.
C. Non sapere di non sapere, riconoscere la possibilità di punti ciechi.
Oltre a ciò che sappiamo e sappiamo di sapere, oltre alle intuizioni che derivano dal non sapere di sapere, dobbiamo fare i conti con ciò che “sappiamo di non sapere” e con ciò che “non sappiamo di non sapere”, cioè con la nostra inevitabile ignoranza e l’ineluttabilità delle zone cieche. Approfondire il modello sistemico implica accettare a fondo l’idea che non sappiamo di non sapere, che a volte intervengono punti ciechi inevitabili rispetto ai quali non possiamo che attendere le retroazioni, consapevoli che possiamo/dobbiamo cambiare per primi noi. Riconoscere il rischio di poter diventare dottor omeostata, di avere ineluttabilmente collusioni e mosse che sono troppo sintoniche con il sistema e non producono cambiamento, porta ad operare riflessivamente e a non porsi lo scopo di attuare una correzione morale, né una riabilitazione psicologico-normativa. Considerare ineludibile questa posizione non è una brutta notizia. Riflettere sulle conseguenze operative oltre che epistemologiche porta ad espandere le proprie lenti: la fiducia nell’ordine che dal disordine può emergere, l’assunzione di responsabilità per il processo in atto. Mi sto riferendo alla necessità che il clinico, abbandonando il mito del controllo, si accontenti di un sapere provvisorio e si adoperi per non comprendere troppo presto e non saturare la conoscenza del sistema. Che si fidi anche delle capacità del sistema di auto-guarigione.
Il secondo aspetto che, secondo von Foerster, dobbiamo mettere in atto al fine di esprimere in maniera indiretta la nostra posizione etica è la dialettica, che si esprime attraverso il linguaggio, inteso come una danza che impegna minimo tre persone nella definizione del problema, nella ricerca delle risorse che emergeranno (dalle interazioni e dal contesto) e nella scelta del posizionamento nel processo condiviso. Sono le azioni comuni come il parlare e la scelta specifica delle parole a creare contesti di significato; sono i passi di danza del linguaggio, con la musica o senza (i contenuti), è la sua dialogicità (l’invito e la necessità a ballare insieme) che determinano le posizioni che assumiamo e l’atteggiamento di rispetto che emergerà nel rapporto con gli altri. “Nella sua funzione il linguaggio va verso, raggiunge gli altri, e questa è la radice della consapevolezza….”. Il linguaggio crea la realtà che tutti insieme in terapia si abita. E’ il bisturi nelle mani del clinico e contemporaneamente l’humus che costruisce la realtà terapeutica. Necessità di un’attenzione costante. Von Foerster si entusiasma della magia della lingua, della sua inevitabile circolarità, dell’invenzione che comporta: le domande che i clinici fanno permettono ai clienti di uscire dal loro solito copione e inventarsi; il processo di invenzione permette ai clienti di uscire dall’usuale e ritrovare percorsi alternativi alle solite narrazioni (ed emozioni) attorno agli stessi problemi.
Lasciamolo continuare: “Intendo permettere alla lingua e alle azioni di scorrere nel fiume sotterraneo dell’etica senza che diventi esplicita, in modo che il linguaggio non degeneri in moralizzazione. L’etica è il dominio in cui siamo noi che ci assumiamo la responsabilità per le nostre decisioni. … Ogni volta che agisco nel qui e ora non solo cambio io ma cambia anche l’universo. Questa posizione lega il soggetto con le sue azioni in maniera inseparabile a tutti gli altri, stabilisce quindi un prerequisito per fondare un’etica.”
Da un punto di vista clinico riferirsi alla dialogica implica:
A. Accedere a posizioni plurime nel rapporto con le narrazioni proposte
Accedere ad un pluriverso, evitare una narrazione unica e un punto di vista unitario, permettere versioni anche contrastanti, elicitare l’irriverenza, de-costruire le premesse delle singole persone e del gruppo in toto al fine di permettere ipotesi alternative e nuove gestalt. Così posizionarsi cognitivamente ed emotivamente in maniera non sempre uguale, accettare la sfida di non credere a ciò che emerge e far accadere altro.
B. Riflettere sui concetti che si utilizzano
Il concetto di famiglia, di coppia, di ciclo di vita e di eventi critici, anche lo stesso termine “genitorialità” che cosa vi fanno venire in mente? Utilizziamo costantemente modelli di riferimento impliciti senza accorgerci che i modelli che utilizziamo non sono sempre i più adatti per affrontare il lavoro e che sono temporalmente e culturalmente determinati. Così termini quali “ossessivo compulsivo”, oppure “borderline”cosa fanno venire in mente in chi li ascolta e quali vincoli inducono nella relazione e nelle singole menti?
C. Mettere in atto una riflessività relazionale
Il nostro focus è centrato sul «pattern che connette» il sistema consulente al sistema committente, attraverso un processo linguistico che mette in atto sia spinte verso la stabilità che verso l’evoluzione. Un processo che non si esplica solo nella stanza di terapia ma coinvolge tutte le persone che partecipano attivamente o meno al processo:
il sistema determinato dal problema che può includere l’inviante, un medico di base, un insegnante, le assistenti sociali del comune e altri.
La responsabilità della responsabilità del clinico
Nell’ottica della cibernetica di secondo ordine e del costruttivismo, ci viene restituita la libertà di affrontare una situazione, e con essa ci viene restituita la nostra responsabilità. Il clinico costruttivista non può non occuparsi di valori, non può evitare di prendere una posizione “politica” e non può esimersi dall’assumersi la responsabilità delle sue azioni. Lavorando con la soggettività dell’altro e con la propria, con le idee e con le emozioni presenti nella relazione, non si limita più ad applicare delle tecniche sulle persone. L’etica diventa implicita, la responsabilità diventa esplicita; la libertà di scelta diventa una possibilità e, se la si assume, un regalo del cielo. Non esiste in clinica un intervento lineare né un solo livello di osservazione/azione. La relazione da cui emergono le narrazioni è basata sulla ricorsività, la doppia posizione del clinico, le operazioni di secondo livello (conoscere la conoscenza, la diagnosi della diagnosi, il cambiamento del cambiamento) che diventano garanzia di circolarità, processualità e curiosità. Non si tratta di acquisire nuove tecniche, di inventare nuove teorie per leggere i sistemi e i contesti, si tratta di riflettere sempre di più sulla propria operatività e sulle mosse che già conosciamo/mettiamo in atto, al fine di costruire una prassi evolutiva e responsabile.
I successi e i fallimenti non dipendono unilateralmente dal clinico o dal sistema che chiede aiuto ma emergono all’interno della storia della relazione e del loro reciproco incontro. Emergono dalla coordinazione della coordinazione di azioni e significati.
Si tratta di agire ricursivamente dentro e fuori la stanza, di riflettere sulle azioni messe in atto (anche le parole sono azioni), di monitorarle e vedere quali effetti pragmatici sortiscono.
Il clinico si trova quindi in una posizione di responsabilità plurime:
- sociale determinata sia dal mandato da parte della società che dal risultato delle proprie azioni nel mantenere/ decostruire strutture di potere
- relazionale che induce a riflettere sul significato che l’espressione della propria competenza assume all’interno della relazione con i clienti e tutti gli altri significativi del contesto condiviso, al fine di instaurare un processo di conoscenza collaborativa, rinunciando alla posizione di esperto
- tecnica: considerarsi competente rispetto ad un modello e alle sue operazioni, passare dal diagnosticare il problema all’esplorare le risorse
- personale:
- Verso gli altri: la voglia e la capacità di mettersi in gioco, la curiosità, la capacità di futurizzare le ipotesi e immaginare percorsi ottimali (processuali, basati sulle risorse)
- Verso se stessi: formazione permanente e disponibilità ad esplorare,
- Verso ambedue: monitorare i propri pregiudizi, tenere una doppia posizione (dentro e fuori), tenersi informati, stimolati, monitorare il burn out, non cadere in pattern ripetitivi, leggere, creare, gestire contesti.
Possiamo parlare di responsabilità della responsabilità che si riferisce al dover rendere conto, per primi a se stessi, del processo di costruzione delle realtà sociali che si realizzano nell’interazione col problema presentato e il sistema di significati implicato. Non c’é bagaglio tecnico né modello epistemologico che possa di per sé dare una direzione evolutiva o stabilizzante all’intervento terapeutico: il significato di ciò che un clinico fa è negoziato attraverso un processo interattivo di cui tutti i partecipanti sono coautori, che viene alla luce attraverso una attenta analisi della domanda.
Il terapeuta non sa meglio e di più degli altri implicati, non ha teorie più vere né oggettive, si pone su più piani contemporaneamente. Ha forse una maggiore consapevolezza delle regole dell’agire umano e di quelle che portano all’evoluzione, e si permette di assumere più posizioni rispetto al sapere. Il clinico opera costantemente una serie di scelte, al fine di costruire il contesto terapeutico (creare uno spazio) e creare la relazione, intesa come collaborazione verso un fine condiviso e negoziato. Per far questo propone azioni e parole consapevoli ma sarà la danza comune a dar significato ad alcune e disperderne altre. E’ la danza comune che decide. Il clinico non potrà sostenere un potere unidirezionale sul gioco che emergerà e dovrà accettare l’asimmetria di ruolo (parità umana e personale, competenze diverse).
Nell’ottica sistemica la terapia diventa una operazione di 2° ordine, assoggettata alla relazione tra tutte le persone implicate.
Come operare quindi in maniera etica , essendo consapevoli dei rischi e dei vincoli?
Ci sono alcune azioni che sono, secondo me, imprescindibili, su due in particolare intendo focalizzarmi:
- Mettere in atto operazioni di secondo ordine e operare quindi riflessivamente
- Tenere sempre a mente possibili esiti indesiderati (collusioni, risonanze, cronicità, rischio del rischio iatrogeno)
- Mettere in atto operazioni di secondo ordine che derivino da una posizione riflessiva da parte del clinico è la prima operazione imprescindibile. La riflessività si nutre della capacità di riflettere non su di sé né sulle categorie impiegate ma sulla relazione tra clinico e cliente e sulla danza che emerge dal loro incontro, alla luce del modello arbitrariamente scelto dal clinico. Come scrive Maurizio Ceccarelli (2008) si tratta di attivare il sistema neocorticale e non semplicemente rispondere a ciò che accade e questa attivazione è stimolata dalla relazione cooperativa che il clinico ricerca. Stando nella relazione, si tratta di attivare la riflessività e trasferirla/condividerla col cliente, sapendo che il fine è quello di ragionare su come le ipotesi, le operazioni e le ridefinizioni che si propongono possono risultare normative (e risultare omeostatiche) oppure evolutive. Questo atteggiamento ci porta a parlare di conoscenza della nostra conoscenza, diagnosi della diagnosi, cura della cura, responsabilità della responsabilità.
- Tenere sempre a mente la possibilità di esiti indesiderati.
Le zone cieche, le collusioni, la possibilità di diventare dottor omeostata, il rischio del rischio iatrogeno (Bianciardi Telfener 1995), sono eventi inattesi che non possiamo non prendere in considerazione, con cui dobbiamo ineluttabilmente fare i conti per rispettare l’etica della processualità clinica. Anche una prassi condotta nel migliore dei modi possibili può condurre ad empasse e portare a un blocco dell’evoluzione del processo o addirittura farlo risultare nullo.
Gli errori all’interno della cornica cibernetica sono segnali che possono aiutare il clinico a correggere la sua strategia (si espletano nel dominio dei comportamenti). La risonanza è inevitabile ed è risolta attraverso il lavoro del team, la super/pari-visione, la riflessione comune. La collusione, la cronicità, il rischio del rischio iatrogeno sono conseguenze inattese che emergono dai processi interattivi anche quando il modello viene applicato correttamente. Fanno parte degli eventi indesiderati quelle situazioni che accadono e ci prendono la mano: un momento in cui ci troviamo troppo invischiati, in cui abbiamo perso la nostra autonomia e pensiamo come pensa il sistema che ha chiesto aiuto, quando non vediamo alternative al pattern usuale di comportamento, quando abbiamo perso la curiosità o costruito una situazione immutabile; quando si è persa la processualità, intesa come la possibilità di svolgere ciò che accade come se fosse un nastro.
La collusione è la spinta a stare al gioco dell’altro, l’aver accettato il suo punto di vista e trovarsi invischiati in un processo che non è evolutivo:
- si perde lo sguardo individuale a favore di quello collettivo;
- si vedono solo alcuni aspetti della realtà terapeutica;
- si fotografa la realtà, la si blocca nel tempo e in una definizione “patologica”;
- si perde la spinta strategica;
- si mettono in campo pensieri/azioni che invece di far evolvere la situazione reificano lo status quo.
Si ha cronicità quando una mappa di patologia viene condivisa da tutti i componenti della rete relazionale che comprende il cliente, i familiari, i curanti, gli invianti: quando tutti sono d’accordo sulla gravità/patologia della situazione e non c’è più nessuno scambio di informazioni.
Il rischio del rischio iatrogeno (iatreia = “cura medica”; gignomai = “nascere”) è l’altra conseguenza inattesa che emerge dai processi interattivi (anche quando il modello viene applicato correttamente) e deriva dalla pratica della cura. Presuppone situazioni in cui si ipotizza che il peggioramento non sia dovuto alla personalità delle persone in cura ma sopravvenga a seguito delle operazioni del curante e al processo in atto. Se pensiamo che gli umani e le situazioni sono in costante divenire, il ruolo dell’operatore diventa quello di non bloccare il cambiamento. Non dobbiamo spingere verso una nuova organizzazione, ma dobbiamo stare attenti a come gli interventi che proponiamo possono fermare/staticizzare una situazione oppure renderla evolutiva. I sintomi più frequenti in questi casi sono un aumento dell’ansia, senso di sgretolamento di sé, senso di trasparenza, pensieri di incapacità e inadeguatezza. Il rischio non è quindi che il terapeuta ignori qualcosa dell’oggetto di conoscenza (questo è inevitabile e salutare), il rischio è che ignori qualcosa di sé, ovvero ignori le caratteristiche costitutive dei percorsi messi in atto e delle proprie modalità conoscitive in rapporto a quelle dei clienti. Che ignori la propria ignoranza. Questo confondere i propri mezzi conoscitivi con la realtà è la radice di ogni possibile rischio di un danno iatrogeno.
Conclusioni
Potremmo chiamare “relazionale” questo atteggiamento verso l’etica, e aggiungere che esso esclude totalmente la possibilità di chiamarsi fuori, di fare una diagnosi da un luogo privilegiato di osservazione, senza occuparsi delle conseguenze delle proprie azioni. Spero che si sia compreso che la mia proposta è quella di considerarsi ineludibilmente parte del processo, nella necessità di osservare le retroazioni e, se non ci piace ciò che è emerso, mutare il nostro atteggiamento, il nostro modo di essere con l’altro/con gli altri, le nostre ipotesi, le nostre teorie su quanto sta avvenendo e sugli altri.
Ho tentato di descrivere l’intervento clinico come quella serie di azioni eseguite da un clinico a) responsabile delle sue azioni, b) consapevole della necessità di scegliere rispetto a decisioni che sono in linea di principio indecidibili, c) attento al proprio linguaggio e alle proprie azioni, d) che mette in atto operazioni sulle operazioni, e) che agisce su se stesso perché è incluso nel sistema, f) che aumenta il numero di scelte per sé e per gli altri, g) che considera ciascuno libero di agire verso il futuro che desidera (rispetto), h) che valorizza l’eterarchia computazionale[3] (valori, scelte che possono cambiare nel tempo e non sono organizzate in maniera razionale e logica). In conclusione, ho parlato della possibilità di costruire una prassi processuale, evolutiva ed etica. Vorrei finire questo breve scritto riportando l’ imperativo etico del mio maestro Heinz von Foerster che ha costituito per molti di noi sistemici uno stimolo alla libertà di pensiero e di azione, fondamentale nella prassi lavorativa:
poiché tutto è incarnato nell’etica agisci sempre in modo da aumentare il numero delle scelte tue e altrui
Note
[1] Fisico, epistemologo, teorico dei sistemi, tra i suoi insegnamenti emerge l’ineluttabilità di una scelta epistemologica, il problema dell’inclusione del soggetto nel processo di osservazione, l’attenzione alle operazioni di secondo ordine – di cui parleremo in seguito – l’insistere sull’abisso della nostra fondamentale ignoranza e l’inevitabilità di porsi da un punto di vista etico.
[2] Il costruttivismo è una concezione integrata dell’essere umano, considerato parte dell’universo e coinvolto nel processo di osservazione.
[3] Heinz von Foerster considerava uno degli articoli più importanti degli anni sessanta quello di McCulloch (in von Foerster, 1974) sull’eterarchia computazionale. In esso l’autore dimostrava che le scelte non sono basate sulla logica ma sull’estro del momento, diversamente da come pensano i logici.
Bibliografia
– Bianciardi M., Evoluzione del pensiero sistemico e pratica clinica, “Riflessioni Sistemiche”, N. 2, 2010. www.aiems.eu
– Bianciardi M., Telfener U., Ammalarsi di psicoterapia, Angeli, Milano 1995.
– Ceccarelli M., Blundo C., La neuropsicologia delle emozioni, Idee in psicoterapia, 3, 2008.
– Foerster H. von, Cybernetics of Cybernetics, Biological Computer Laboratory, Urbana 1974.
– Foerster H. von, Ethics and Second Order Cybernetics. Relazione al Congresso internazionale “Éthique, Idéologies, Nouvelles Méthodes”, Parigi 4-6 ottobre 1990.
– Telfener U., Gli errori in terapia familiare sistemica: uno strumento di apprendimento, “Archivio di Psicologia Neurologia Psichiatria”, N. 3-4, pp. 513-30 1985.
– Telfener U., Gli insuccessi della terapia, in F. Piccini e D. Bavestrello (a cura di), Insuccessi in psicoterapia, Angeli, Milano 1996.
– Telfener U., Apprendere i contesti, strategie per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro, Raffaello Cortina, Milano 2011.
– Telfener U., Casadio L., Sistemica. Voci e percorsi nella complessità, Bollati Boringhieri, Torino 2003